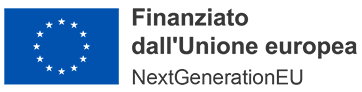Funded under the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), Mission 4 Component 2 Investment 1.3, Theme 10.
Economia circolare, processi innovativi e nuove tecnologie green per valorizzare gli scarti alimentari
Intervista con Antonio Moretti, direttore ad interim dell’ISPA, l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, e coordinatore dello Spoke 2 “Sistemi alimentari e di distribuzione intelligenti e circolari”.

Giulio Burroni
Communication manager
La perdita e lo spreco di cibo rappresentano due grandi sfide per la resistenza e la resilienza del sistema alimentare, la cui attuale frammentazione sta generando insicurezza alimentare per due miliardi di persone a livello globale.
Le cifre sono ormai note: si stima che circa un terzo di tutto il cibo prodotto a livello globale rimanga invenduto, perso o sprecato in qualche punto lungo la catena di approvvigionamento, che va dalla produzione fino alle nostre tavole.
Ma è importante tenere a mente che lo spreco non è solo nel consumo, ma anche e soprattutto nelle fasi di produzione, logistica e distribuzione.
Nel contesto dell’Economia Circolare dei sistemi agroalimentari, uno dei temi caldi è la valorizzazione degli scarti alimentari per la creazione di nuovi alimenti funzionali. La riduzione dello spreco alimentare, attraverso l’identificazione di metodi innovativi per il recupero e il riutilizzo dei residui alimentari, è infatti un passo fondamentale verso modelli di consumo e produzione più sostenibili.
Lo Spoke 2 di OnFoods, visto nel suo complesso, punta a "chiudere il cerchio" dal ciclo di riuso di prodotti alimentari. Adotta un approccio di ricerca integrato per la gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari, attraverso il lavoro di quattro principali work packages (WP), tutti orientati allo sviluppo di tecnologie verdi e biotecnologie, processi innovativi e soluzioni digitali.
Ne parliamo con Antonio Moretti, direttore ad interim dell’ISPA, l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, e coordinatore dello Spoke 2 “Sistemi alimentari e di distribuzione intelligenti e circolari”.
Le ricerche dello Spoke 2 di OnFoods saranno presenti a Cibus Tec Forum mercoledì 29 ottobre con un focus a più voci su food system circolari, sostenibili e sicuri.
Dott. Moretti, il superamento del modello di produzione lineare è il grande tema di questi anni. Ma, nonostante quello di “economia e transizione circolare” sia un concetto di gran moda – nato, peraltro, diversi decenni orsono – definirlo resta problematico. Varie le proposte, ognuna in grado di sottolineare un aspetto. Vogliamo provare a fare il punto, anche rispetto al settore agroalimentare?
In ambito agroalimentare il concetto di economia circolare non è certamente nuovo; esistono da millenni pratiche agronomiche e di trasformazione alimentare orientate alla circolarità, anche a livello domestico: tradizionalmente si è sempre cercato di riutilizzare tutto, limitando gli scarti, ovvero i prodotti non più salubri.
Potremmo portare molti esempi tratti dalla storia dell’alimentazione umana che si basano su un uso oculato delle risorse e dei cosiddetti prodotti di scarto alimentari. Da questo punto di vista, il settore agroalimentare è circolare ante-litteram, sebbene nel tempo si sia adeguato al modello economico consumistico che è in contrasto con le regole di riuso più di buon senso.
Nell’ambito dell’attuale ricerca scientifica, ciò che viene definito scarto è spesso una miniera di composti bioattivi che devono essere “semplicemente” estratti, stabilizzati, e trasformati al fine di poterli incapsulare in prodotti con maggiore contenuto nutraceutico.
Il problema è poi riuscire a elevare le proprietà funzionali di questi prodotti e incontrare il gusto del consumatore nel rispetto della sicurezza, e quindi convincere l'opinione pubblica che l’uso di queste tecnologie, non solo non rappresenta un rischio, ma che, anzi, aggiunge valore nutraceutico e salutistico agli alimenti, oltre che ottemperare alle esigenze di uso responsabile delle risorse energetiche.
È chiaro che in ottica della transizione circolare la riorganizzazione dei processi di approvvigionamento vada assolutamente ripensata, perché il modo in cui ancora è prassi procedere, sia nella produzione sia nella logistica, ha un impatto notevole sull'ambiente e sulla salute: un processo di cambiamento per nulla scontato.
Per comprendere e attuare la transizione verso la circolarità non basta una logica rigenerativa, serve – per usare un anglicismo – un approccio "restorative": pensare a ricostituire il capitale naturale laddove ciò è effettivamente possibile. La ricerca sulla valorizzazione dei sottoprodotti alimentari va in questa direzione? Le normative che cornice danno? Sono sufficienti?
OnFoods ha lavorato già molto sulla preservazione della biodiversità, studiando proprio gli scarti provenienti da differenti varietà vegetali, e anche caratterizzando enzimi da microrganismi purificati o isolati direttamente da essi.
Per adottare queste tecnologie occorre una normativa che sappia comprendere quello che sta facendo la scienza, perché la ricerca può sperimentare e caratterizzare infinite applicazioni, e poi pensare anche a un'estensione, ma queste applicazioni devono essere sempre coerenti con la legislazione vigente.
L'EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, fa un grande lavoro in questo senso, dando linee guida ben definite su cosa si può o non si può applicare.
Ma a uno stadio successivo sta al legislatore interpretare, soprattutto nel nostro Paese. E il legislatore è spesso condizionato dai gruppi di pressione e dall'esigenza di non perdere consenso o di attirare facile consenso; quindi si punta sulla “tradizione” assumendo un atteggiamento quantomeno “morbido” verso nicchie d’opinione anti-scienza che si oppongono all’innovazione promossa dalla ricerca scientifica.
Di conseguenza, esistono buchi normativi che devono essere colmati e su questo è necessario intervenire.
Quanto pesa sul vostro lavoro l’opinione pubblica su certi temi, come usa dire, “divisivi”?
Dal lato dell'opinione pubblica e dei consumatori vediamo sia persone molto informate, con un alto livello di consapevolezza, ma anche una buona fetta di persone esposte alla disinformazione.
La qualità e l'affidabilità dell'informazione scientifica è in questo cruciale: per quanto riguarda lo Spoke 2, ad esempio, è importante far comprendere quanto ribadivo in precedenza, e cioè che il sottoprodotto alimentare non è sempre un rifiuto o un prodotto di minor valore nutrizionale, ma può essere un vero e proprio tesoro.
Prendiamo ad esempio la ricotta, che viene venduta in grandi quantità nei nostri caseifici e supermercati. Questo alimento viene prodotto a partire dal siero di latte, un sottoprodotto della lavorazione dei formaggi. Grazie a questo processo di valorizzazione, il consumatore oggi apprezza le proteine del siero e il basso contenuto di grassi della ricotta, piuttosto che considerarla semplicemente uno scarto.
Ma esistono altri sottoprodotti e materiali di scarto che possiedono un enorme valore nutraceutico e un nostro obiettivo è di far comprendere che ciò che viene spesso percepito come rifiuto può essere in realtà una risorsa preziosa e nutrizionalmente ricca.
Il lavoro dello Spoke 2 è delineato attraverso quattro principali work packages (WP), tutti orientati allo sviluppo di tecnologie verdi e biotecnologie, processi innovativi e soluzioni digitali. L'obiettivo principale del WP 2.1 è quello di ridurre l'impatto ambientale, trasformando i rifiuti in risorse utili. Il lavoro si concentra dunque sul recupero dei rifiuti e sulla loro valorizzazione attraverso tecnologie di pretrattamento e l'estrazione di composti bioattivi. Può spiegarci come funzionano questo genere di studi e qual è al momento il potenziale di mercato di queste tecnologie innovative?
Il potenziale applicativo è elevatissimo e già tantissime aziende stanno passando dalla scala di laboratorio alla scala pilota per poi arrivare a impianti che sfruttano le economie di scala, riducendo i costi del processo.
Tra l'altro, in questo Work Package c'è anche una parte di studio dedicato alla valutazione dell'acquisizione attraverso i cosiddetti process developments che ci mettono in contatto diretto anche con altri Spoke per ottenere prodotti che hanno uno sviluppo sostenibile.
Da questo punto di vista, lo Spoke 2 ha ampia possibilità di utilizzare le molecole che estraiamo attraverso processi a bassissimo impatto ambientale. Definiamo questi processi "green" proprio perché non utilizzano solventi o metodologie potenzialmente tossiche. La possibilità di sviluppo in questi ambiti è inoltre strettamente legata alla collaborazione con le imprese, per le quali il problema principale – ricordiamocelo – rimane la sostenibilità economica. Ma su questo fronte si stanno facendo enormi progressi.
In sintesi, integriamo differenti competenze che spaziano dalla biologia all’ingegneria, dalla diagnostica avanzata basata anche sull’analisi sensoriale alla chimica in un approccio olistico sulla tematica. Nonostante le attività dello spoke siano divise in 4 WP lo sforzo che stiamo facendo è quello di far interagire il più possibile le varie attività, incontrando anche le tematiche presenti negli altri Spoke.
Questi processi ci portano in modo diretto al WP 2.2 che si occupa della riduzione dei rifiuti attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni di bio-packaging, sanitizzazione e stoccaggio. Questo segmento si basa sui sottoprodotti alimentari che derivano da vari settori come frutta, verdura, cereali, legumi, pesce, alghe, olio d'oliva, caffè, vino e prodotti lattiero-caseari. L’obiettivo è dunque migliorare la conservazione dei prodotti e diminuire di conseguenza gli sprechi alimentari. A che punto siete dello sviluppo di queste nuove soluzioni?
Ci troviamo a un punto del lavoro cruciale rispetto agli obiettivi generali dello Spoke. Una delle tecniche più interessanti utilizzata in diversi laboratori – all'Università di Bologna ma anche al Cnr a Bari – è l'uso del plasma (da non confondere col plasma sanguigno) per trattare l'ortofrutta.
Il plasma è uno stato della materia costituito da un gas ionizzato, composto da elettroni liberi, ioni e altre specie reattive. Applicando energia elettrica all'aria, che contiene ossigeno, azoto e vapore acqueo, si genera il plasma a pressione atmosferica. Le specie reattive prodotte dal plasma, come radicali e ioni, hanno quindi potenziali effetti antimicrobici e possono essere utilizzati per trattare la superficie di frutta e verdura. È una tecnologia di cui la ricerca ha testato un ampio livello di sicurezza, e che sta portando ottimi risultati dal punto di vista della riduzione della carica microbica presente sugli alimenti. Al momento, siamo al livello di studio pilota e quello che stiamo cercando di capire è come il processo sia realmente applicabile. Sono tecniche molto innovative che si stanno diffondendo un po' in tutto il mondo e che ci danno risultati oggettivamente molto interessanti.
Stiamo anche studiando e ottimizzando alcuni processi biotecnologici per la sperimentazione con microrganismi capaci di valorizzare le matrici (materiali di partenza o substrati: ndr) e inibire la crescita di altri microrganismi che vengono considerati alteranti e potenzialmente patogeni.
Come ISPA, e fuori dalla cornice OnFoods, stiamo lavorando su prodotti fermentati locali in un progetto europeo Horizon 2020, UP-RISE, che vuole contribuire a costruire un sistema di sicurezza alimentare in Africa, in collaborazione con tre partner Europei e con cinque partner africani. L’obiettivo è caratterizzare la flora microbica presente sui prodotti fermentati in grado di ridurre i rischi di contaminazione da sostanze tossiche di natura naturale come le micotossine.
Proseguendo tra le aree di lavoro, vi siete occupati anche di gestione dei rifiuti. In questo caso l’attività si concentra sull'implementazione di un framework digitale per monitorare e gestire la catena di imballaggio e i sistemi di supporto decisionale. L’idea è di analizzare gli scarti durante tutta la filiera alimentare, dalla produzione fino alla distribuzione degli alimenti. Ma per monitorare, ad esempio eccedenze e scarti delle imprese agroalimentari, servono dati e per averli serve anche consapevolezza e collaborazione da parte delle aziende. Come vi muovete su questo fronte? Com’è lo stato dell’arte della trasparenza e del monitoraggio delle filiere in Italia?
È un po' a macchia di leopardo: ci sono delle aree di impresa con delle punte avanzate di consapevolezza e altre in cui si è ancora indietro. Le aziende più grandi hanno ormai l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità in forma di bilancio e quindi sono già in grado di monitorare esattamente come impattano nel loro processo di produzione e distribuzione. Il tema è sentito anche perché si capisce sempre di più che la sostenibilità non rappresenta un vincolo ma un'opportunità di innovazione e profitto.
Ma è cruciale garantire la qualità dei dati sulla sostenibilità aziendale, considerando la copertura e l'omogeneità, in vista dell'adozione dal 2025 degli standard contabili EFRAG/ESRS per la rendicontazione sulla sostenibilità. E sebbene questi nuovi standard non si applichino direttamente alle piccole e medie imprese, queste ne risentiranno attraverso le filiere. Pertanto, è essenziale che le imprese sviluppino una consapevolezza crescente sull'importanza dei temi ESG. Successivamente, sarà sempre più necessario adottare la cosiddetta disclosure ESG, cioè la divulgazione di informazioni relative agli impatti e alle performance ambientali, sociali e di governance delle aziende, al fine di ottenere valutazioni monetarie adeguate o migliori condizioni di accesso al credito.
E quindi, il tema della sostenibilità aziendale è sempre più intrecciato a quello dell’innovazione e sarà sempre più anacronistico parlare di innovazione escludendo la sostenibilità e viceversa. Ma in un Paese a predominanza di piccole e micro imprese, con poche grandi aziende in grado di competere a livello globale, innovare in modo sostenibile non è scontato.
Esatto. Per quanto riguarda il problema dell'innovazione tecnologica la questione dimensionale delle aziende italiane è cruciale. Ma è un limite della politica rinunciare a comprendere che la dimensione aziendale, o perlomeno l'associazionismo delle piccole aziende, è una chiave per poter implementare l'innovazione tecnologica, per far fare il salto di competitività al Paese. L'innovazione tecnologica migliora non solo le condizioni economiche di tutto il Paese ma anche quelle dei lavoratori, perché ogni impresa che innova, acquista competitività, ed è in grado di garantire ai propri dipendenti migliori condizioni di salario e di lavoro. Il cosiddetto nanismo delle imprese italiane andrebbe visto anche come opportunità e non solo come problema.
Le opportunità, insisto, ci sono: dovremmo puntare sulla flessibilità e sulla capacità di innovare attraverso la cooperazione in filiere produttive globali, come dimostrano alcuni distretti industriali italiani. Sulla valorizzazione delle competenze artigianali e del "genius loci" che caratterizzano il Made in Italy. Sulla possibilità delle imprese di crescere dimensionalmente attraverso passaggi generazionali e aggregazioni, sfruttando la finestra di opportunità offerta dai cambi di management.
La politica dovrebbe quindi promuovere l'innalzamento del livello di istruzione e l'innovazione, per aumentare la competitività delle piccole e medie imprese, e quindi favorire la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione, senza snaturare il modello di piccola impresa innovativa tipo del nostro Paese.
Infine, arriviamo al WP 2.4 che, sempre utilizzando soluzioni digitali avanzate, punta a ottimizzare la distribuzione dei prodotti agro-alimentari, assicurando catene di fornitura sostenibili. Monitoraggio, fornitura, trasporto e consegna sono i punti su cui si concentra il lavoro di quest’area con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e di creare un'economia più circolare a beneficio di tutte le parti interessate.
Parliamo di soluzioni di logistica green e di logistica urbana: ci può spiegare più nel dettaglio in cosa consistono queste nuove strategie e come sono applicabili?
Il lavoro consiste nella riclassificazione delle pratiche utilizzate nella logistica, per controllare successivamente lo stato dei prodotti nel corso di tutta la filiera. Stiamo elaborando un metodo rapido basato su una nuova generazione di sensori che monitorano lo stato di conservazione degli alimenti. Questa metodologia potrebbe avere un impatto positivo su tutto il settore food.
Si tratta di un trend d’innovazione che osserviamo un po’ ovunque: la logistica sta rivoluzionando le modalità di approvvigionamento dei prodotti, grazie anche all'integrazione di sensoristica e sistemi smart che forniscono informazioni cruciali sulla conservazione e alterazione.
Per quanto riguarda l’applicazione di queste soluzioni attualmente siamo ancora in una fase preliminare. Guardiamo, però, ai risultati con ottimismo: stiamo ricevendo dati molto confortanti dai colleghi del Politecnico di Milano che lavorano su questo ambito.
L’approccio integrato tra le varie aree di lavoro dello Spoke 2 è particolarmente apprezzabile in due grandi progetti di ricerca come EXTRA-BIO e CHARACTER-BIO.
Estrazione prima e valorizzazione poi dei composti bioattivi derivanti da biomasse agricole: ci spieghi come funziona questo lungo processo che parte dagli scarti, utilizza metodi estrattivi per il recupero di biocomposti per realizzare nanotecnologie applicabili ad esempio nel packaging bioattivo.
Il processo parte dalle matrici, ognuna con determinate caratteristiche, e successivamente vede l’impiego di differenti solventi per capire in quali condizioni si può estrarre una specifica molecola. Tutto il processo di estrazione è messo a punto nel progetto EXTRA-BIO. Poi, entra in gioco il progetto CHARACTER-BIO, che si concentra sullo studio delle caratteristiche di queste molecole: le molecole possono essere caratterizzate o come ingrediente alimentare per le loro potenziali applicazioni o caratteristiche biochimiche, oppure possono essere destinate al packaging.
È necessario che progetti del genere siano interconnessi: si parte dalla messa a punto delle caratteristiche di estrazione e dalla proposta dei composti; poi si passa all’analisi della loro composizione per capire se hanno mantenuto le caratteristiche originali oppure hanno adottato quelle che si intendevano estrarre. Questa interazione si basa sul dialogo tra competenze diverse, ciascuna indispensabile: lavorano insieme chimici, biochimici, agronomi, tecnologi alimentari, e anche microbiologi.
Ma sappiamo che la lista di progetti di Spoke 2 non termina certo con EXTRA BIO e CHARACTER BIO; sono infatti circa 30 le progettualità che ricadono su Spoke 2 e tra queste la componente aziendale è abbastanza presente. Penso ai progetti di ricerca con Sacco e De’Longhi. Ma anche ai molti coordinati da CNR ed ENEA.
Quanto pesa la ricerca applicata nel vostro ambito di lavoro? Quali secondo lei le differenze da valorizzare, o appianare, tra approccio d’impresa alla ricerca e approccio accademico?
Sono due approcci culturalmente differenti: il ricercatore ha l'obiettivo di comprendere ciò che sta indagando, di arrivare a un nuovo risultato, che possa contribuire ad aumentare la conoscenza sul tema che sta studiando. Al contrario, l'impresa vuole applicare il risultato e utilizzarlo, con l’obiettivo del profitto.
Tuttavia, nello Spoke 2 abbiamo trovato una buona capacità di interazione con le aziende . Vorrei citare il lavoro che insieme al mio gruppo di ricerca stiamo facendo con la De’ Longhi. Il nostro team di ricerca chimica sta collaborando allo sviluppo di nuove macchinette da caffè per valutare come ridurre la quantità di chicchi di da caffè utilizzare, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche del prodotto finale, con conseguente riduzione degli scarti di lavorazione. Da questo punto di vista, c'è una bella integrazione tra i vari aspetti del processo. Tuttavia, è chiaro che questi aspetti applicativi si basano su uno studio preliminare di base molto approfondito: siamo in grado di analizzare le sostanze volatili del chicco e determinare se un processo causa la perdita di fragranza perché prima abbiamo studiato come analizzare, caratterizzare e identificare le varie sostanze volatili.
In questo progetto stiamo osservando la capacità dell'impresa di riconoscere e affrontare le difficoltà che possono sorgere durante la fase di applicazione, cercando di risolverle.
In generale, è evidente che la capacità di trasferimento tecnologico è uno degli aspetti fondamentali della ricerca. Abbiamo incontrato aziende molto consapevoli di questo e stiamo ottenendo ottimi risultati.
Citava prima il suo gruppo di lavoro all'ISPA, l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, che lei dirige ad interim. La vostra attività spazia dalla messa a punto di metodologie innovative per il controllo di contaminanti e microrganismi negli alimenti, alla valorizzazione di produzioni alimentari tipiche e locali. Ma siete anche un punto importante nella cinghia di trasmissione ricerca-imprese nel Paese. Quali sono le esperienze e lecompetenze che dal CNR, lei porta in OnFoods?
Sicuramente, raccolgo il frutto del lavoro svolto dal precedente direttore, un lavoro di team eccezionale in cui si distinguono alcuni ricercatori che desidero citare: Marco Montemurro, Angelo Santino e Tonia Gallo. Abbiamo una capacità di organizzazione fondata sull’integrazione delle competenze, perché il nostro è un istituto multidisciplinare: ci sono agronomi, chimici, microbiologi, tecnologi alimentari. Queste competenze diversificate ci permettono di affrontare le problematiche nel loro complesso. Inoltre, abbiamo una lunga tradizione di collaborazione sia con le grandi multinazionali sia con le piccole imprese, e ci distinguiamo come punti di riferimento internazionali per la sicurezza alimentare e la qualità alimentare. Siamo leader mondiali, ad esempio, sulla tematica delle micotossine, un campo che desidero citare nonostante non sia specificamente correlato a questo Spoke.
Il fatto di avere un'autorevolezza internazionale, l'abitudine al lavoro di networking e a creare grandi reti di cooperazione scientifica, ci ha permesso di gestire efficacemente questa organizzazione complessa quale lo lo Spoke e di stabilire ottimi rapporti di collaborazione con i tanti gruppi di ricerca coinvolti nel progetto e appartenenti a diversi atenei.
La mia esperienza è sempre stata quella di lavorare su due binari: un grande lavoro di ricerca e uno sguardo attento alle imprese. Abbiamo collaborato con grandi aziende mantenendo sempre l'integrità dei dati, il che ci ha consentito di interagire pienamente con tutti gli attori coinvolti nello Spoke. Nel nostro lavoro, ci impegniamo a mantenere la coerenza e credo che i risultati positivi siano evidenti per tutti.
Credo che l'argomento dell'economia circolare sia indubbiamente una tematica scientifica che noi, come Istituto, continueremo a promuovere, coerentemente con le linee strategiche del Cnr. E ritengo che il nostro Spoke stia ottenendo risultati molto positivi: abbiamo ricevuto eccellenti valutazioni dal Ministero.
È importante anche riconoscere il lavoro dell'apparato amministrativo che supporta i ricercatori, ma è essenziale sottolineare che per rendere davvero efficace la ricerca nel nostro Paese, le procedure devono essere semplificate. Altrimenti, rischiamo di restare indietro mentre altri Paesi procedono più velocemente.